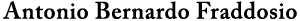17 Nov Le Grande Arche de la Fraternité, l’albero di Sankara
di Floriana Carosi
“… I semi che abbiamo seminato in Burkina e nel mondo sono qui. Nessuno potrà mai estirparli. Germoglieranno e daranno frutti.
Se mi ammazzano arriveranno migliaia di nuovi Sankara…”(Thomas Sankara – Dal Discorso sul debito, Organizzazione per l’Unità Africana, Addis Abeba, 29 luglio 1987)
Il 15 ottobre del 1987 veniva ucciso Thomas Sankara, il presidente del Burkina Faso, leader carismatico la cui prematura scomparsa, all’età di 37 anni, ha cambiato il destino dell’Africa incidendo pesantemente sui ritardi di una crescita economica e democratica dell’intero continente. Eppure grazie alla lungimiranza e alla forza trascinatrice di questo rivoluzionario presidente, per quattro anni, a partire dal 1983, il Burkina Faso, “la terra degli uomini integri” – paese nato dall’Alto Volta, colonia alla quale la Francia concesse l’indipendenza formale nel 1960 – visse una rinascita senza precedenti.
Sankara ebbe “il coraggio di inventare il futuro” per il suo paese definito come “un concentrato di tutte le disgrazie del mondo” e lo dimostrò adoperandosi per affrancare il popolo africano dalla morsa del colonialismo e soprattutto dalla nuova e persuasiva forma di schiavitù finanziaria, quella del debito. Egli intuì che bisognava riprendere le redini del continente con le proprie forze e liberarsi da certe tradizioni obsolete; iniziò cambiando il nome di Alto Volta, retaggio del periodo coloniale, in Burkina Faso e si impegnò per eliminare la povertà attraverso il taglio degli sprechi statali e la soppressione dei privilegi delle classi agiate; finanziò un ampio sistema di riforme sociali incentrato sulla costruzione di scuole, ospedali e case per la popolazione in estrema povertà; diede avvio a programmi per la promozione dello sport e l’ampliamento della rete dei trasporti pubblici, oltre a condurre un’ importante lotta alla desertificazione con il piantamento di dieci milioni di alberi per il rimboschimento del Sahel.
Il programma politico di Sankara ebbe inoltre a cuore il miglioramento delle condizioni delle donne poiché egli sosteneva che “la rivoluzione e la liberazione delle donne vanno di pari passo”. Un’ idea molto evoluta questa di Sankara che fa coincidere la lotta per i diritti sociali con quella per i diritti civili poiché imprescindibili gli uni dagli altri. L’emancipazione delle donne, inoltre, non era un “atto di carità o di compassione umana”. Si trattava di “…una necessità alla base della rivoluzione. Le donne reggono l’altra metà del cielo”. Inserì così le donne nella vita politica e militare del paese addirittura incoraggiandole a ribellarsi al maschilismo imperante.
Ma il vero grande coraggio, Sankara lo dimostrò da subito, quando si rifiutò di saldare gli assurdi debiti pretesi dagli ex coloni (“…che non moriranno se non ripagheremo il debito, mentre il nostro popolo si”), suggerendo di istituire un nuovo fronte economico africano da contrapporre a quello europeo e statunitense al fine di rendere il paese autosufficiente e libero da importazioni forzate. Incentivare la produzione e l’economia locale significava porre fine alla schiavitù economica dell’Occidente. Per questo sosteneva nei suoi discorsi “bisogna produrre, produrre di più perché è normale che chi vi dà da mangiare vi detti anche le sue volontà”.
Divenuto personaggio scomodo, troppo scomodo, soprattutto per il piano egemonico mondiale messo in atto dai poteri finanziari internazionali attraverso lo strumento del debito, “il presidente ribelle” fu ucciso dal suo collaboratore nonché successore Blaise Compaoré, verosimilmente appoggiato da potenze occidentali.
La figura di Thomas Sankara, nato nell’Alto Volta e morto nel Burkina Faso, che indicò la strada verso il progresso al suo popolo e non solo, poichè …”D’altro canto le masse popolari europee non sono opposte a quelle africane anzi, quelli che vogliono sfruttare l’Africa sono gli stessi che sfruttano l’Europa. Abbiamo un nemico comune…”, ha ispirato ad Antonio Bernardo Fraddosio un’originale opera che l’artista definisce “di collegamento” tra i due cicli “Salvarsi dal naufragio” e “Quello che resta dello sviluppo”.
La produzione artistica di Fraddosio negli ultimi venti anni si svolge come un grande componimento senza finale dove i cicli rappresentano capitoli che trattano temi universali e le opere rappresentano pagine. I diversi cicli si sovrappongono attraverso alcuni lavori che, come in questo caso, fanno da raccordo e concorrono alla costruzione del “filo rosso” del grande componimento. Sono opere attente al contenuto, perché, scrive Fraddosio: “l’artista non si può accontentare di presentare come opere d’arte le proprie sperimentazioni formali, gli effetti di un evento o di una condizione esistenziale personale…In questo momento storico l’arte deve fare essa stessa politica, mettere contenuto nelle opere e non solo. Gli artisti devono mettere la politica, nella sua accezione più alta, nel loro lavoro. Tutta la produzione artistica che non si ispira a questo principio, per me fondamentale, è ormai da considerarsi stantia, ridotta a mera decorazione, a orribile operazione finanziaria gestita da ricchi per i ricchi”.
Il ciclo “Salvarsi dal naufragio”, come scrive lo stesso artista, è legato “al tema del grande esodo o, meglio, deportazione dei popoli del sud del mondo verso il nord”. L’opera centrale del ciclo, “L’isola nera 2013 annus horribilis”, presente nelle collezioni del MACRO di Roma, nasce da un drammatico episodio che accadde nell’ottobre del 2013 quando, al largo di Lampedusa, a seguito di un naufragio, morirono 388 migranti. Si tratta di un polittico costituito da dodici formelle che rappresentano i dodici mesi dell’anno 2013. Per realizzarle, l’artista si pone nella posizione visiva del migrante paradossalmente consapevole che quel grumo nero, l’isola, che rappresenta per lui una speranza, è in realtà esso stesso un barcone nella tempesta. Le formelle recano dei sottotitoli composti dal mese, anno, numero degli sbarcati e numero di morti. L’artista rileva che nel gennaio 2013 sono sbarcate appena 227 persone, nove mesi dopo, il numero sale a 9200; come è possibile che all’epoca, nessun governo si rese conto che dietro quei numeri si nascondeva la drammatica realtà, ormai inarrestabile, del fenomeno migratorio? Scrive Fraddosio: “A me parve chiaro che quello che all’inizio sembrò essere l’esodo di disperati che fuggivano da guerre e fame, stava diventando una vera deportazione di massa…In un mondo ormai globalizzato dal nuovo capitalismo che concentra sempre più le ricchezze nelle mani di pochi, era necessario globalizzare anche la forza lavoro” Con queste parole l’artista esprime il suo pensiero sull’evoluzione apocalittica di certi eventi e fenomeni inizialmente sottovalutati da tutti, soprattutto dai cosiddetti poteri forti, proprio quelli che hanno poi dato una spinta determinante a scatenarli.
In continuità con “Salvarsi dal naufragio” nasce il ciclo successivo “Quello che resta dello sviluppo” che vede nell’installazione “Le tute e l’acciaio” la sua opera più rappresentativa.
Dieci “tute di ferro”, dieci cassoni in acciaio ossidato, al cui interno alloggiano altrettante lamiere modellate come panneggi metallici, lacerate, incendiate. Le tute sono quelle indossate dagli operai degli stabilimenti siderurgici ex Ilva, oggi Arcelormittal Italia, per “difendersi” dai tumori provocati dalle polveri letali.
L’installazione, che è stata esposta da novembre 2018 a maggio 2019 presso la GAM di Roma nell’ambito della mostra “Antonio Fraddosio. Le tute e l’acciaio”, costituisce quindi un potente tributo alla tragedia dimenticata dell’ex Ilva di Taranto e alle sue vittime.
Quello che doveva essere un esempio di crescita, di benessere, di progresso si era trasformato in un assurdo strumento di morte e distruzione. A Taranto, la più grande acciaieria d’Europa non ha mai smesso nel tempo di provocare morti tra operai, cittadini e bambini a causa dei gravi effetti dell’inquinamento e del degrado ambientale.
Come è possibile che i progressi realizzati dall’uomo negli ultimi duecento anni si risolvano in questo terribile scenario di autodistruzione? E’ lo stesso artista a fornirci una risposta: “Semplicemente perché non si trattava di reale progresso bensì solo di sviluppo di tecnologie. Lo sviluppo non è sinonimo di progresso, ma come affermava Pier Paolo Pasolini, spesso ne rappresentava l’opposto. Il primo mette al centro le tecnologie, il secondo l’uomo e il suo pensiero”. Quindi, se lo sviluppo non è accompagnato da una adeguata crescita di pensiero, produce inevitabilmente danni e il degrado ambientale è opera del modo in cui si evolve lo sviluppo globale.
La sistematica distruzione dell’ambiente e dell’uomo è realizzata attraverso una precisa e attenta strategia tesa solo al raggiungimento dei massimi profitti economici in tempi rapidi all’interno di un sistema economico-finanziario globalizzato in cui l’uomo, prigioniero delle lobbies di potere, è costretto sempre più ad una condizione di servilismo.
Un artista impegnato e “militante” come Antonio Fraddosio rimane affascinato dalla figura dell’eroe rivoluzionario burkinabè Thomas Sankara, profeta della libertà e della giustizia, che, con fiducia e coraggio, si era schierato a parole e nei fatti dalla parte degli oppressi, del mondo rurale, delle donne; persino degli alberi.
Ed è proprio un albero che ha ispirato lo scultore per l’opera che, nella versione definitiva, sarà realizzata a grandezza naturale, in lamiera di ferro incendiata e collocata all’aperto.
Il Sankara di Fraddosio è un albero, quasi sradicato, inaridito dall’incuria dell’uomo e dall’ostilità del clima che si piega ad arco, si allunga, quasi si spezza fino a toccare terra con i suoi rami. Quei rami secchi, accennano ad un corpo, (quello di Sankara), con le braccia protese verso la terra. Da quel corpo, apparentemente senza vita, da quelle braccia-rami, che si infilano nella terra arida africana, come per margotta, nasce una nuova pianta collegata alla pianta madre.
L’”albero-Sankara” ricorda la Dafne berniniana a cui è legato dal tema della metamorfosi.
Nel gruppo scultoreo berniniano, nel momento di massima tensione drammatica, Apollo afferra Dafne nell’istante in cui è iniziata la trasformazione del suo corpo in pianta di alloro.
Nell’opera di Fraddosio invece il passaggio di forma avviene in senso inverso e doppio: una pianta morente si trasforma in un essere umano e nelle sue idee di rinascita e attraverso le sue braccia-rami darà origine ad una nuova pianta.
E’ inoltre forte il richiamo nell’opera sia al tema della ciclicità, del passaggio morte-vita presente già in lavori precedenti dell’artista come “Mater Matuta”, sia al messaggio di speranza della “Venere di Palestina”, anche questa opera di collegamento, dove il corpo di donna, avvolto in un sudario di lamiera contorta che le copre il volto e le trafigge il ventre, emana una forte sensualità a significare “disperata vitalità”.
Le opere di Fraddosio possono essere definite – come ha detto lo scrittore e drammaturgo Rocco Familiari – dei veri e propri “ racconti” per le sensazioni che rappresentano e suggeriscono; anche questa va osservata attentamente da varie prospettive, lontano, intorno, attraverso ma anche molto da vicino per scoprirne alcuni dettagli dalla forte valenza simbolica come l “ombelico-vulva” che l’artista realizza sul corpo – albero, al centro dell’addome, la cui immagine vivificatrice è rafforzata dalla presenza dell’organo sessuale maschile che si intravede subito sotto.
L’ombelico è il centro della vita, il centro generatore per eccellenza, attraversato da tutti i flussi vitali, compresi quelli che alimentano il feto, che nasce dalla vulva. L’artista torna ai temi della fecondità, della riproduzione, della rinascita e della vita che, non a caso, ben si legano alla figura della donna tanto cara a Sankara che aveva fatto dell’emancipazione femminile uno dei punti cardine del suo programma politico.
L”’albero-Sankara” parte dalla terra e torna verso la terra formando un grande arco che dà il titolo all’opera e che polemicamente richiama “Le Grande Arche de la Fraternité” di Parigi conosciuto anche con il nome di “Grande Arche de la Défense”.
Nel 1983, anno in cui Sankara divenne presidente, a Parigi iniziarono i lavori per la costruzione del “Grande Arche de la Fraternité”, concepito come una versione del XX secolo dell’Arco di Trionfo dell’Etoile, perché fosse un monumento consacrato all’umanità e agli ideali umanitari piuttosto che alle vittorie militari. Fu il presidente francese Françoise Mitterand che commissionò il monumento al fine di prolungare l’asse storico di Parigi, la cosiddetta via Trionfale, costituita da un insieme di edifici, monumenti e strade che si estendono verso Ovest a partire dal centro, dal cortile del Louvre al Grande Arche de la Défense, appunto, nel distretto Paris La Défense, nel dipartimento degli Hauts-de-Seine.
L’arco fu inaugurato nel 1989, due anni dopo l’assassinio di Sankara, nel bicentenario della Rivoluzione francese.
Oggi il “Grande Arco della Fraternità”, ubicato nel quartiere degli affari più grande d’Europa, La Défense, caratterizzato dalla presenza massiccia di centri commerciali, grattacieli ed uffici, strutture dedicate alle aziende e al business, spicca per la particolarità della sua forma pressoché cubica ricoperta di marmo bianco di Carrara, granito e vetro e ospita al suo interno uffici governativi ed un centro congressi ed esposizioni. Ecco come il mondo ricco, in particolare l’Occidente, ha concepito gli ideali di libertà, uguaglianza, fratellanza fra gli uomini; quello stesso mondo che nel 1987 ha ucciso Sankara e dopo due anni ha voluto celebrare la prima vera “Rivoluzione” nella storia, quella del 1789, con un monumento consacrato agli ideali umanitari nel cuore del business della capitale francese.
Fraddosio, nel cogliere questa forte contraddizione e forse nel tentativo di superarla attraverso l’arte attribuisce al suo “Grande Arco” un significato originale. Egli trascende la sua definizione di elemento strutturale in architettura per renderlo un luogo di “attraversamento simbolico”. Mediante l’arco, l’opera comunica con lo spazio circostante e attiva misteriosamente percezioni nascoste all’osservatore che lo attraversa e che riesce a sentire e appunto percepire maggiormente il messaggio dell’opera.
In epoca romana il passaggio sotto l’arco di Trionfo aveva un significato ben preciso per il condottiero: la memoria delle vittorie militari ma allo stesso tempo un cambiamento di stato, il ritorno ad una condizione di normalità dopo la guerra, una sorta di purificazione, un ritorno all’innocenza e alla pietas dopo le uccisioni e le stragi compiute.
Allo stesso modo attraversare “Le Grande Arche” di Fraddosio significa effettuare un atto simbolico, una sorta di purificazione, di rinnovamento individuale e universale, ma nel contempo significa dare risalto al valore della memoria, per non dimenticare l’uomo Sankara e soprattutto le sue idee di rinascita che in qualche modo avrebbero cambiato il mondo ma che comunque non sono state vane. Inoltre, attraversare l’arco significa tornare a riflettere sul tema della ciclicità della vita tanto caro all’artista: l’arco parte da terra con le radici che muoiono e torna a terra con la nuova pianta che cresce.
L’opera, quale studio preparatorio in scala ridotta per il monumentale “Grande Arche”, costituisce una fase dell’originale processo creativo dell’artista, che trova nel disegno la sua prima funzione ideativa.
Gli interessanti schizzi per l’opera eseguiti a china non sono soltanto studi grafici dell’idea ma “rappresentazioni emotive”, come lui stesso li definisce, poiché in essi “l’artista-architetto” intuisce già la tridimensionalità dell’immagine, il suo sviluppo nello spazio.
Questo modello in scala ridotta che segue appunto lo studio grafico non ha più nulla di improvvisato, è già un’opera a sé stante, dotata di una propria autonomia e di completezza artistica che “l’artista-architetto” realizza con materiali di recupero, di cantiere, di cui ben conosce il valore espressivo, le potenzialità tecniche ed i risvolti segreti.
La struttura interna dell’albero-arco è costituita da un’armatura di ferro dolce che l’artista piega e adatta all’andatura della forma secondo la sua visione estetica. La struttura viene avvolta da canapa e tela di juta precedentemente impregnati di un impasto di stucco, cemento e gesso che creano sulla superficie affioramenti di materia modellati con le mani dall’artista per dar loro una qualità estetica.
Questi semplici materiali sono magistralmente plasmati dall’artista per ottenere l’effetto materico del legno dell’albero e la straordinaria fedeltà mimetica del tronco nodoso e possente, con i suoi profondi anfratti che ricorda gli alberi secolari del Burkina Faso.
La composizione, fissata su un carrello, poggia su una base cosparsa di polvere di ferro e pozzolana, materiali utilizzati per replicare la terra rossa africana.
Con questa opera Fraddosio dimostra ancora una volta di essere un artista-intellettuale politico, che utilizza il lavoro artistico per raccontare la verità, per rappresentare la realtà e condannare un potere di cui siamo tutti prigionieri. L’arte non è autoreferenziale. L’arte può essere un mezzo di cambiamento.
Del resto, Fraddosio ama ripetere le parole di Picasso: “Che cosa credete che sia l’artista un imbecille che ha solo gli occhi, se è un pittore… no, egli è anche un uomo politico, costantemente sveglio davanti ai laceranti, ardenti o dolci avvenimenti del mondo… La pittura non è fatta per decorare gli appartamenti. È uno strumento di una guerra offensiva e difensiva contro il nemico”. L’arte in generale è quindi una guerra che va combattuta con i propri strumenti, con il proprio linguaggio anche se indiretto, evocativo, ed in questo risiede la sua forza sovversiva: nell’opposizione ad uno status quo e nella costruzione di una realtà alternativa.
Da qui l’aforisma di T.W. Adorno: “ogni opera d’arte è intrinsecamente rivoluzionaria”.
In alcune recenti interviste, l’artista, ha spesso citato le parole del poeta italo-new-yorkese Lawrence Ferlinghetti, poeta di spicco della beat generation, recentemente scomparso, che, nella raccolta intitolata “Poesia come arte che insorge” (2009), a proposito della sua idea di poesia, scrive:
“Ci sono tre tipi di poesia. La poesia supina accetta lo status quo. La poesia seduta scritta dal sistema seduto ha una verità dettata dal suo lavoro di giorno. La poesia in piedi è la poesia dell’impegno, a volte grande, a volte terrificante.
L’idea di poesia come braccio della lotta di classe disturba il sonno di coloro che non vogliono essere disturbati nella ricerca della felicità.
Il poeta per definizione è portatore di Eros e amore e libertà e quindi nemico naturale non violento dello Stato.
È ultima Resistenza.
Il poeta è un barbaro sovversivo alle soglie della città che sfida costantemente il nostro status quo”.
Secondo l’artista l’idea di poesia di Ferlinghetti può essere traslata a tutte le altre forme di arte. Parole e immagini sono chiamate a condividere gli stessi spazi e a veicolare, ove possibile, lo stesso messaggio. Linguaggio artistico e parole corrono parallele si compenetrano nel senso, uniscono le proprie forze espressive e linguistiche per raggiungere il lettore/osservatore.
Gli artisti militanti alternano l’impegno socio-politico a lirismo puro cosi come l’esigenza di condannare le storture di questo mondo ferito e sofferente si alterna alla volontà di affermare speranza e possibilità di riscatto.
Quella di Fraddosio, artista “barbaro sovversivo” è quindi l’Arte “in piedi” di Ferlinghetti, un’arte di grande impegno che manifesta la propria forza politica, “che sfida costantemente lo status quo” attraverso la forma e la felicità espressiva.
Scrive ancora Ferlinghetti: “Se vuoi essere un poeta, crea opere capaci di rispondere alla sfida dei tempi apocalittici, anche se questo significa sembrare apocalittico”.
Nel “poeta-apocalittico” di Ferlinghetti c’è tutto Antonio Fraddosio ed il suo lavoro artistico.
Floriana Carosi