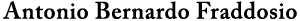22 Dic “L’arte può salvare il mondo?”
di Alberta Campitelli
L’accostamento di due artisti dalla diversa formazione e che si esprimono in modo diverso è spesso rischioso, perché non sempre il visitatore della mostra riesce a cogliere i nessi, le trame di dialoghi che si intessono, le corrispondenze più o meno esplicite. Nel caso di Antonio Fraddosio e Claudio Marini si ha a prima vista l’impressione di un diverso percorso, basato su scelte stilistiche non omogenee, sebbene entrambi abbiano un elemento comune nella bandiera.
Quelle “interpretate” da Claudio Marini, recentemente nere ma prima anche con colori sgargianti e accostamenti arditi, come sono in realtà, si confrontano con le opere di Fraddosio dove dominano i neri e i colori neutri quali il sabbia ed il bianco sporco, e si rilanciano l’un l’altra un medesimo tragico messaggio. Le bandiere di Marini sembrano a prima vista “realistiche”, seppur interpretate “artisticamente”, ma a ben guardare ci si rende conto che l’autore non ha solo manipolato la tela con l’uso materico di smalti o con lo stropicciamento della tela stessa, ma ad ognuna di esse ha aggiunto qualche elemento che ci connette direttamente con il popolo che la bandiera rappresenta, con i drammi che quel popolo sta vivendo o ha vissuto, dalla dolorosa e ingiusta crisi della Grecia alle fragili e spesso sanguinose primavere arabe fino alla tragedia del Giappone con l’esplosione della centrale nucleare di Fukushima. Per apprezzare il messaggio di Marini è necessario che lo spettatore sia in grado di giungere all’emozione attraverso quella che potremmo chiamare una sorta di “cognizione del dolore”, un dolore che attraversa il nostro mondo in modo davvero globalizzante.
Il messaggio di Fraddosio è più diretto e l’impatto con la grande bandiera nera chiusa in gabbia, con il movimento della “tela” rattrappito e congelato tra le sbarre, trasmette immediatamente un messaggio drammatico. La gabbia, simbolo di per sé di costrizione, incombe sulle nostre teste, con all’interno qualcosa che, come corpo vivo, cerca contorcendosi lo spazio nel quale collocarsi. Una bandiera ben lontana da quelle che vediamo nelle rassicuranti cerimonie ufficiali, con i colori nazionali che si dispiegano nell’aria e, per dirla retoricamente, “garriscono al vento” mentre il popolo raccolto si emoziona in un ritrovato senso di appartenenza. Non meno forti nel loro impatto sono le altre opere scultoree, assemblaggi di legni, cemento, ferri, trattati con grumi di catrame e colori terrosi, che con margini seghettati, punte, tessiture materiche e sfaldamenti, inducono subito sentimenti di inquietudine. Non sono certo rassicuranti i titoli che Fraddosio ha dato alle sue opere, che contengono termini come “lesioni”, “scissure”, “distorsioni”, “ruderi”, come non rassicuranti sono i colori che usa, che negano ogni ottimismo: emblematico è il titolo di un’opera e della bella mostra che si è tenuta a Lucca nel 2012, “Luce nera”.
È quindi una mostra di grande e tragica attualità, che ci obbliga a confrontarci con il dramma di un mondo nel quale, ormai, la guerra e la violenza sono ovunque e si manifestano in mille imprevedibili forme. Ci insegna a vedere la pittura e la scultura in continuità con la realtà, come parte di essa. Per noi italiani il titolo della mostra è di immediata comprensione: mai nella nostra storia la parola naufragio ha assunto tale portata, ogni giorno ci viene gettata addosso in tutti i notiziari, fa parte ormai del nostro quotidiano. E abbiamo tutti capito che non c’è salvezza individuale, che il nostro mondo deve ritessere una rete di solidarietà, che tutti dobbiamo essere protagonisti di un ritrovato sentire come cittadini del mondo. Può l’arte contribuire a questo? Noi crediamo di sì e le belle parole del messaggio ad artisti ed intellettuali, rivolto dal Ministro della Cultura greco, che Gabriele Simongini cita a conclusione del suo emozionante saggio, sono illuminanti.
Come è stato detto, non è la cultura che fa le rivoluzioni, ma senza cultura non ci sono rivoluzioni, e compito dell’arte, oggi, è aiutarci a percepire, attraverso le opere, il mondo intorno a noi in tutta la sua complessità.
A conclusione vorrei raccontare il mio legame personale con Antonio Fraddosio, risalente alla fine degli anni Novanta del secolo scorso e in un contesto totalmente diverso. Antonio lavorava presso il Provveditorato dello Stato e io ero impegnata nel recupero degli edifici e del parco di Villa Torlonia. Lui mi contattò perché, grazie ad alcune vecchie foto conservate nell’archivio del quotidiano “Il Tempo”, aveva individuato in alcuni mobili giacenti in un magazzino, quelli che arredavano la camera da letto del principe Giovanni Torlonia e che, nel 1925, era divenuta di Benito Mussolini. Il duce, infatti, aveva avuto dal principe in affitto, ad un canone simbolico, tutta la villa di via Nomentana e vi risiedette con la famiglia fino all’arresto avvenuto nel luglio 1943. Con Antonio Fraddosio e con l’allora sindaco Francesco Rutelli, si decise di restaurare i mobili e di ricollocarli nella sede di provenienza, contribuendo con un tassello ulteriore al recupero del complesso e della sua memoria storica. Così i mobili sono stati ricollocati e fanno bella mostra nel Casino nobile della Villa, in un percorso tra arte e storia che, senza alcun intento nostalgico, ha voluto ricostruire tutte le fasi di un importante periodo della nostra storia. Questo episodio, certamente minore rispetto ai tanti ed impegnativi lavori condotti nella Villa, è a mio parere importante come dimostrazione di una corretta collaborazione tra istituzioni, di un metodo di lavoro che, nel rispetto delle competenze, mira al bene del nostro patrimonio culturale. Da quella collaborazione è nata l’amicizia e la “scoperta” di un Antonio Fraddosio artista e mi piace ricordare che questa è una delle ultime mostre da me organizzate come direttore del Museo Carlo Bilotti, quasi un suggello alla mia quarantennale presenza al Comune di Roma, tra conservazione e ricerca.
Alberta Campitelli