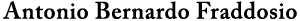19 Nov “Ecce homo: sudari di ferro”
di Gabriele Simongini
“Tanto il tumore, se ti viene, ti viene
dopo; e comunque, se vivi qui,
te lo prendi anche se non lavori”.
Un operaio, addetto in cokeria, all’Ilva
“Avete fatto voi questo orrore, maestro?”, chiese a Picasso con tono di scherno un ufficiale nazista, alludendo a “Guernica”. “No, l’avete fatto voi”, rispose seccamente il vulcanico artista. Qualcosa del genere, fatte le debite proporzioni, dovrebbe accadere di fronte all’installazione “Le tute e l’acciaio” che Antonio Fraddosio mette in campo come un potente atto di denuncia contro quell’apocalisse di stato rappresentata dalla tragedia dell’Ilva di Taranto. Ma se nel caso del bombardamento di Guernica i responsabili erano immediatamente riconoscibili, nella vicenda del mostruoso impianto siderurgico tarantino, il più grande d’Europa, i colpevoli sono tanti, troppi, in un nauseante intreccio fra amministrazioni locali e governi centrali, pessime commistioni fra politica ed imprenditoria spregiudicata, ambiguità di certe aree dell’ambientalismo, strane e sospette ingerenze da parte anche delle istituzioni comunitarie e di una certa magistratura e via discorrendo. E in fin dei conti la vicenda dell’Ilva è emblema di quel massacro etico, sociale ed economico che riguarda tutto il Sud, dall’Unità d’Italia in avanti. Tanto che oggi risuonano tragicamente paradossali le parole con cui il 10 aprile 1965 il Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, inaugurò ufficialmente l’impianto di Taranto: “Io sono qui per solennizzare l’entrata in funzione di un grande stabilimento industriale. E anche in questa occasione voglio recare agli italiani del Mezzogiorno l’assicurazione che lo Stato ha preso effettivamente e seriamente coscienza della realtà meridionale e si adopera per mutarla”. Così la netta presa di posizione di Fraddosio è anche quella di un uomo del Sud, per di più pugliese di nascita, che ha visto con i propri occhi, tante volte nel corso degli anni, quell’abominevole trasformazione di Taranto che la testimonianza dell’artista stesso rende meglio di altre parole: “Arrivavo da Martina Franca, dove era nata mia madre, in auto. Era sera. Dall’alto della collina che degrada verso il mare guardai, Taranto non c’era più. Vidi un Inferno di fuoco e di fumo. La più grande acciaieria d’Europa aveva mangiato la città, la campagna e aveva bevuto il mare”. Era nato un mostro che presto avrebbe divorato tutto, così come all’improvviso aveva ingoiato i ricordi familiari di Fraddosio, quando quella terra non era stata ancora stuprata e resa irriconoscibile. In fin dei conti quella che un tempo ormai molto lontano era la città degli ori, tuttora ammirabili nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto, si è poi trasformata nella città dell’acciaio, del ferro, del carbonio, dove il diritto al lavoro lo si guadagna dando in cambio la propria salute, la propria vita e ipotecando anche quelle dei propri cari, con una venefica consuetudine che oggi, sempre di più, si sta diffondendo in tutto il mondo globalizzato. In pratica a Taranto si è realizzato un drammatico processo alchemico all’inverso della sua stessa identità: invece che la mitica trasformazione del piombo in oro qui ha preso corpo l’esatto contrario ed, anzi, qualcosa di molto peggiore, una sorta di flagello inarrestabile che è cancro e devastazione ambientale. Dove è finita la vera vocazione di Taranto, legata al mare, anzi, addirittura a due mari? Nel luglio del 1959, durante un epico viaggio intrapreso su una Fiat Millecento per raccontare l’estate degli italiani, Pier Paolo Pasolini, che di lì a poco si interrogherà sulla differenza sostanziale fra “sviluppo” e “progresso”, scriveva: “Taranto è una città perfetta. Viverci è come vivere nell’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta. Qui Taranto nuova, là, gremita, Taranto vecchia, intorno i due mari, e i lungomari”. Come ha notato Alessandro Leogrande alla fine del 2017 in un articolo appassionante, “nelle pagine di Pasolini, la simbiosi tra mare e città, tra il mare e i suoi abitanti, nell’alternarsi dell’eterno gioco dei sessi tra le onde e gli scogli, appare perfetta”. Poi, l’inizio dell’apocalisse: il 9 luglio 1960, viene posata la prima pietra dell’Italsider, il più grande stabilimento siderurgico italiano e per la sua costruzione vengono estirpati, si dice, 40.000 alberi d’ulivo secolari. Alla fine il centro siderurgico finì con l’occupare oltre 1500 ettari di superficie, con un’estensione pari ad oltre il doppio della città. E sorse in una posizione fisicamente e tragicamente attaccata alla città, con una venefica osmosi che non prevedeva nessuna tutela per gli abitanti e moltiplicata anche dalla presenza dell’impianto petrolchimico e del cementificio. Ed aveva ragione ancora Leogrande a parlare di “un’intera città che ne soppianta un’altra, senza che i suoi abitanti se ne accorgano”, citando un romanzo fantascientifico di Philip Dick, “La città sostituita”.
Ora, con l’installazione “Le tute e l’acciaio”, l’apocalisse di Taranto e dell’Ilva arriva nel cuore della capitale e tramite queste opere il termine “apocalisse” riacquista la sua etimologia originaria di “scoperta” e “disvelamento”. Sì, dobbiamo farci i conti fisicamente e psicologicamente con queste lamiere zincate dismesse, lacerate, contorte, accartocciate, sporcate di ossido e di acidi, bruciate, sofferenti. Si riferiscono alle tute che gli operai, finito il turno di lavoro, depositano in una specie di camera di compensazione prima di andare alle docce e che dovrebbero difenderli dai tumori. Il titolo di ogni opera fa seguire al ricorrente “Dieci tute di ferro” la sigla e il numero atomico di uno dei metalli che compongono le polveri di emissione. Ma al di là di tutto e soprattutto al di là delle parole, sono solo la forma e la materia che recano in sé vaghe impronte di corpi umani sconvolti da una sorta di tempesta apocalittica, da un’irredimibile furia devastatrice, da un morbo che ha inquinato anche l’anima. Questa è la forza di Fraddosio, il quale, pur nell’impeto dello sdegno e della denuncia, non si lascia dominare dalla notazione sociologica o antropologica, per quanto sia impressionante, ma cerca ossessivamente la verità emotiva ed esistenziale che si invera nella forma, intesa come presenza ineludibile e come testimonianza inevitabile. E poi la capacità di unire in un ossimoro sconvolgente eleganza e terribilità, grazia e violenza, costruzione e distruzione, nella verità della materia, fa pensare, mutatis mutandis, come possibili termini di paragone ai “Ferri” o alle Plastiche combuste di Burri ma anche, in qualche modo, agli “Otages” di Fautrier e alla loro duplicità, a quell’essere al tempo stesso carne da obitorio e possibile feto. Di fronte alle opere di Fraddosio quasi sentiamo e vediamo l’energia del calore degli altiforni siderurgici ma non ci sfugge l’aerea e pur residua leggerezza di strani panneggi metallici o di manti lacerati, animati da un loro movimento interno e da riflessi promananti un’ardua e cangiante bellezza. In questi sudari di ferro resta l’impronta di corpi umani sofferenti, c’è il senso della morte e della distruzione ma sopravvive una sorta di speranza affidata all’arte, alle sue possibilità catartiche. C’è la tempesta bollente di un’apocalisse tutta terrena e per nulla trascendente ma anche l’afflato potenziale di un vento purificatore che porti un po’ d’aria e di luce fra quelle carcasse tormentate, fra quegli anfratti inquieti. Tutto convive e coesiste, anche se l’impegno prioritario di Fraddosio è quello di toccare i nostri nervi scoperti per non farci chiudere gli occhi in un letargico e purtroppo sempre più attuale sonno delle coscienze. Un’indifferenza, prima di tutto politica ed istituzionale, che non ha mai voluto sentire nel corso degli anni le rare voci che lanciavano un grido d’allarme. Basta ricordare quanto scriveva sul “Corriere della Sera” Antonio Cederna, nel 1971, definendo la vicenda tarantina “un processo barbarico d’industrializzazione. Un’impresa industriale a partecipazione statale, con un investimento di quasi 2000 miliardi, non ha ancora pensato alle elementari opere di difesa contro l’inquinamento e non ha nemmeno piantato un albero a difesa dei poveri abitanti dei quartieri popolari sotto vento”. Ed ancora oggi, lì, a Taranto, non si annienta solo il presente ma si marchia col fuoco della morte anche il futuro, visto che c’è un oggettivo e purtroppo progressivo incremento di gravi patologie legate all’inquinamento ambientale, soprattutto in età pediatrica. La distruzione della quotidianità nelle sue implicazioni vitali (la salute, il lavoro, ecc.) chiamata in causa dalle lamiere contorte di Fraddosio fa venire alla mente, per certi aspetti e pur in tutt’altro contesto, un episodio de “L’amica geniale” di Elena Ferrante, l’esplosione improvvisa e misteriosa di una grande pentola di rame in una sera normale come tutte la altre, una pentola deformata da un grande squarcio e con i bordi sollevati e ritorti, emblema di un minaccioso presagio e della rottura drammatica di tutti gli equilibri, di tutti i valori, di tutte le certezze, nel cuore di una casa come tante con il suo affollarsi di fragili esistenze.
Se molti associano il colore della morte al nero oppure a quello della terra dove si viene sepolti, a Taranto esso è simile ad un venefico manto di ruggine, una polvere pesante, rossastra, dalle sfumature marroni e nere, che avvolge e soffoca la città colpendo soprattutto il rione Tamburi, a ridosso dell’Ilva. Lo si vede bene negli scatti del reportage “Rosso Tamburi” realizzato dal fotografo barese Christian Mantuano. E così anche nelle lamiere di Fraddosio, ciascuna rigorosamente diversa dall’altra, affiorano spesso quei colori velenosi, mortali che si fanno sentire pure nei cassoni realizzati come contenitori per le singole opere e che richiamano strutture di edifici o di stabilimenti industriali, forme scabre, minimali, potenti, cariche di una loro silenziosa tensione drammatica. E in una giornata particolarmente ventosa, durante la mostra romana, potrà capitare che le lamiere si agitino sbattendo sui supporti che fanno parte integrante dell’opera. Se altrove il vento porta aria fresca e rinnovata, a Taranto è invece latore di morte, come ha raccontato lo stesso Mantuano commentando il proprio reportage: “Quando soffia il vento, il primo luogo della città a essere sommerso dal benzene e dalle polveri è proprio il Tamburi. Anzi, come lo chiamano i tarantini, i Tamburi. La gente che ci vive ogni giorno combatte una guerra che sembra essere senza fine. I bambini giocano in parchi la cui erba è completamente bruciata dal minerale; i pensionati, quasi tutti ex operai dell’Ilva, trascorrono il tempo in strada lavando ogni mattina marciapiedi e muretti completamente ricoperti di polvere”. E in una sua foto è immortalata una “lapide” realizzata dagli abitanti di alcune strade del Tamburi che merita di essere ricordata: “Nei giorni di vento nord-nord/ovest veniamo sepolti da polveri di minerale e soffocati da esalazioni di gas provenienti dalla zona industriale “Ilva”. Per tutto questo gli stessi “MALEDICONO” coloro che possono fare e non fanno nulla per riparare”. Così come non possono essere dimenticati quei grandi timbri o marchi stampati sui muri di Taranto come funebri esempi di Street Art con la scritta “Attenzione città inquinata” e con un teschio che indossa una maschera antigas.
L’impegno fisico e psicologico, la vera e propria fatica fabbrile che Fraddosio ha messo in campo nella realizzazione di queste “tute”, di queste paradossali “armature” di un regressivo medioevo tecnologico, partono da una sorta di ideale empatia ed identificazione, mutatis mutandis, del lavoro dello scultore con quello dell’operaio, naturalmente con tutti i privilegi e le difese di cui gode l’artista. Ed è lo stesso Fraddosio a raccontarci con coinvolgente passione questo corpo a corpo che si carica di sofferenza e di dolore: “uso lamiere zincate della dimensione di due metri per uno, all’incirca. Vengono utilizzate in edilizia per schermare il cantiere, nelle campagne per costruire recinti o creare capanni di protezione e ricovero per gli animali. E’ lì che le trovo, dismesse dal loro uso funzionale perché con il tempo perdono la zincatura ossidandosi parzialmente e diventando, così, inutilizzabili. Indosso una tuta antigraffio, scarpe da cantiere con la punta metallica e guanti da lavoro per proteggermi da tagli e abrasioni. Comincio a modellare la lamiera con le mani, le braccia, i piedi e le ginocchia. Lavoro con tutto il corpo. Spesso capita che per dare forma voluta alla lastra di metallo debba assumere posizioni e fare movimenti del tutto innaturali. Utilizzo spessori e corpi solidi di varia dimensione e forma per realizzare le estroflessioni: martello, mazzetta ed altri per creare squarci, rotture, tagli, frastagliamenti e avvallamenti. E’ una grande fatica fisica che si esaurisce alle volte in molte ore di lavoro ininterrotto. Un notevole impegno anche mentale perché progetto e realizzazione dell’opera sono un unico atto. Il risultato è un panneggio metallico spiegazzato, accartocciato, lacerato, sporcato da tracce di ossidazione, bruciature e acidazioni che realizzo sulla superficie prima e dopo averla modellata”. Così questa installazione, che per scelta di Fraddosio resterà un unicum nel suo percorso per una sorta di profondo rispetto verso la vicenda drammatica dell’Ilva, porta con sé, davanti ai nostri occhi, l’impatto potente di una catastrofe formale ed esistenziale, al tempo stesso, con un’osmosi che non ammette separazioni fra azione artistica e densità emozionale. Ne è protagonista, in senso universale, la fragilità della vita umana, che nessuna corazza o tuta di ferro, forgiata con la letale pozione di ipocrisia, cinismo e avidità, può tutelare o proteggere.
Gabriele Simongini