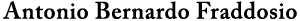30 Nov “Scenografia, parerga o paralipomeni?”
di Rocco Familiari
Il problema del rapporto fra varie parti costituenti lo spettacolo teatrale è vecchio come il teatro stesso, ma è recente, anche se non è difficile rintracciare, nella sua storia millenaria, precedenti illustri in tal senso, la teorizzazione della “pari dignità” degli elementi che concorrono a realizzare la sua “unità”, diciamo da Wagner in qua per l’opera lirica e da Appia e Craig per il teatro di prosa.
La progressiva enfatizzazione del ruolo del regista (analogamente a quanto avvenuto, in parallelo, per l’orchestra, in cui al primo violino, che dava anche il tempo, restando l’esecuzione un’operazione collettiva, si è via via sovrapposto il Direttore, solitario, autentico demiurgo dell’interpretazione) ha portato con sé, per un verso, una riduzione dell’importanza della parte letteraria, anche se essa rimane, comunque, contro ogni tentativo di ridimensionamento, la struttura portante dell’evento teatrale, per l’altro, un maggiore coinvolgimento della figura dello scenografo, chiamato sempre più spesso a costruire sofisticati meccanismo e, comunque, a sottolineare, con immagini di forte valenza simbolica, il significato rintracciato dal registra fra le righe o le pieghe del testo messo in scena, quasi mai, come dovrebbe essere naturale, nel corpo dello stesso…
Ironia a parte, in opere che hanno bisogno di mediazioni interpretative per essere fruite, come il teatro o la musica, l’apporto di varie sensibilità, culture, personalità, per fare emergere tutti i possibili livelli di lettura di un testo, così come di una partitura, è essenziale.
Ha avuto scarsa eco in Italia, se non fra una ristretta cerchia di specialisti soprattutto di musicologia (per una sua opera fondamentale, “L’opera musicale e il problema della sua identità”) la riflessione del fenomenologo polacco Roman Witold Ingarden (maestro, fra gli altri, di Wojtyla e anche, dal ’59 al ’61, di K. Zanussi), il quale ha teorizzato la concezione del dramma come “partitura” (che è anche alla base dell’opera di Wyspianski e ritornerà in Grotowski), nella “Fenomenologia dell’opera letteraria” del ’31 (nonché nel successivo “Von den Funktionen der Sprache in Theaterschauspiel”). La nozione fondamentale è la “stratificazione” del prodotto artistico (strato fonico, dei significati delle parole e delle frasi, degli oggetti denotati, dell’apparenza degli oggetti). L’interpretazione dell’opera d’arte consiste quindi nel ricostruire l’articolazione dei vari strati.
Per quanto riguarda, in particolare, l’interpretazione del testo teatrale, Ingarden attribuisce importanza fondamentale alle parole recitate che servono non soltanto a descrivere l’azione, ma connotano i personaggi attraverso tutta la gamma dei “segni” utilizzati sulla scena, gesti, espressioni del viso, timbro, colore, intonazione.
Assimila così l’”esecuzione” dell’opera “scritta”, anzi del dramma “letto”, all’esecuzione musicale, che “elimina le lacune o i punti di indeterminatezza che compaiono nell’opera musicale”.
Da ciò, a mio parere, la necessità che autore e interprete siano persone diverse. Personalmente, salvo rarissime eccezioni, trovo mortificanti le esecuzioni di opere musicali da parte degli stessi autori, come se questi, anche quando tecnicamente bravi direttori o solisti, fossero incapaci di estrarre, dalle proprie creazioni, tutta la ricchezza di significati che esse contengono.
Basti ascoltare l’incisione della “Sagra della Primavera” diretta da Strawinsky stesso e confrontarla con quella interpretata da Boulez. Piatta la prima, addirittura banale, insuperabile invece quest’ultima, per acutezza di analisi, densità, profondità. La cosa, anche se può apparire paradossale è, invece, pienamente coerente con la natura dell’opera d’arte, che è quella di avere un’esistenza autonoma, quindi di poter andare al di là delle “intenzioni” del suo creatore e trascenderlo. Altrimenti è una cosa non viva, che non aggiunge alcunché all’esistente. Inutile.
Non c’è da sorprendersi, pertanto, se lo stesso autore è ignaro della molteplicità di significati che essa contiene. Non si spiegherebbe, se non fosse così, la capacità dell’arte di interessare popoli di culture le più lontane fra loro e di mantenere inalterata tale capacità nei secoli.
Anche per il dramma vale lo stesso principio. Certo, la parola ha meno livelli di opinabilità di un accordo e “les modes de valeur e d’intensité” attengono più alla musica e alla poesia che a una piéce, ma esiste sempre una parte oscura, ignota allo stesso autore, che soltanto sensibilità diverse, quelle degli interpreti innanzitutto, possono scoprire.
Personalmente, nelle poche regie che all’inizio della mia attività teatrale ho curato, ho sempre preteso la collaborazione di artisti – pittori o scultori – per le scenografie e non per avere delle “firme” illustri, ma soprattutto per confrontare il mio punto di vista – di esegeta della parola, che doveva lavorare su un testo da interpretare, far rivivere, per mezzo di attori nei quali le parole si incarnavano – con quello di chi era abituato a interpretare la realtà con una diversa sensibilità, una capacità di “visione”, non solo in senso letterale, più sincretistica, se così posso dire. Il risultato è sempre stato innanzitutto un arricchimento reciproco, ma anche un approfondimento dell’interpretazione e quindi una moltiplicazione dei livelli di fruizione dello spettacolo.
Quando ho proposto al regista di questo spettacolo di commissionare la scena a Fraddosio, che è sì architetto e quindi certamente capace di costruire una “prigione” e una “stanza”, che sono i due soli ambienti in cui si svolge il dramma dei protagonisti de “L’odore”, ma è, soprattutto, uno scultore, capace di evocare, con le sue “pareti viventi”, la prigione in cui ciascuno di noi vive, speravo che dal contatto fra due diversi “mondi di visione” uscisse arricchito il livello di lettura di un testo che mette in scena passioni disperate e quindi non può essere trattato alla stessa stregua di un dramma politico o di una commedia di evasione.
La scena, in questo, doveva essere funzionale ed evocativa al tempo stesso.
Operazione analoga a quella felicemente attuata con la Fioroni, per il precedente “Orfeo Euridice”.
Gli autori, in genere, sono sempre insoddisfatti o, addirittura, si sentono traditi (basti per tutti la reazione di Pirandello, così efficacemente descritta da Orazio Costa che assistette dal vivo, dietro le quinte, alla prima di un testo del nostro maggiore drammaturgo, il quale si tirava i peli della barba e si graffiava il viso…).
Se, quindi, io ritengo positivo l’esito, non dovrei essere sospettato di… partigianeria.
La prigione inventata da Fraddosio è certamente una prigione, con tutti gli elementi topici di una prigione, le pareti, le sbarre, le porte di ferro. Ma è anche qualcos’altro, e quella torretta di letti, altra gabbia nella gabbia, su cui i due detenuti si arrampicano come scimmie, è un’immagine che, dagli occhi, passa dentro le viscere degli spettatori. Il muro è il muro sporco di una cella, che separa dal mondo, ma è anche una parete che crea una lacerazione dentro, sconnette i pensieri e, insieme, rinserra le passioni, costringendole poi a esplodere.
Così come quella sorta di “compact”, lavello-lavabo-cucina-bugliolo, diventa un totem dedicato alle funzioni fisiologiche elementari, alle quali la detenzione riduce un essere umano.
Anche il letto di Maria, luogo di piacere, diventa, con quella testiera formata da due spalliere metalliche intrecciate, un’altra gabbia, che racchiude altre passioni, pronte anch’esse a evolvere in maniera imprevedibile.
Scena, quindi, non come una chiosa, un commento, un “parerga”, secondo l’elegante espressione classica resa celebre da Schopenauer, ma come “paralipomeni”, vale a dire uno sviluppo, un proseguimento del testo, una sintesi visiva illuminante dell’azione.
È Steiner che autorevolmente sostiene che l’unica forma di interpretazione possibile è la creazione di un’opera “derivata” da quella che si vuole interpretare. Nel teatro questo è possibile se l’autore è così umile da accettare che il suo testo venga integrato, completato, dagli altri elementi dello spettacolo e se il regista, lo scenografo, il musicista, il coreografo, il datore di luci, gli attori infine, sono, a loro volta, consapevoli dell’importanza del proprio ruolo, ma anche della necessità di non prevaricare il testo del quale, in definitiva, si nutrono.
È sempre, per restare ai classici, una questione di misura, di equilibrio.
Rocco Familiari