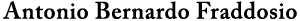19 Nov “Antonio Bernardo Fraddosio e la fatica di essere artista”
di Sergio Rossi
Se c’è oggi un esponente che nella sua produzione racchiude come pochi altri i concetti di “fatica di mente“ e “fatica di corpo” come qualcosa di complementare e non più di antitetico questi è Antonio B. Fraddosio. Architetto, pittore, scultore, scenografo, intellettuale, come definire il nostro artista? Ecco proprio quest’ultimo termine, nella sua onnicomprensività, è quello che meglio rappresenta Fraddosio, che sta ormai emergendo come una delle personalità più originali e interessanti del nostro panorama contemporaneo. «Ma, come giustamente osserva Pedrag Matvejeviç, l’originalità di questo scultore, pittore, disegnatore e poeta, è tutto ciò contemporaneamente, non si lascia ridurre a facili analogie né costringere dentro abituali categorie. L’originalità non è garantita in anticipo, né nell’opera e neppure nel nostro approccio ad essa», ed in Fraddosio è proprio la sintesi e la conseguenza del processo creativo insito in ogni vero artista.
In lui si sostanzia infatti il rapporto dialettico tra istinto e ragione, ispirazione e metodo, caos e ordine, classico e anticlassico (che possono poi ricondursi in ultima analisi alla filosofia aristotelica e alla sua poetica del “fare” da un lato ed alla filosofia neoplatonica ed alla sua poetica del “creare” dall’altro) rapporto dialettico che è alla base stessa di ogni fare artistico e che si è di volta in volta sostanziato nei contrasti tra Rinascimento e Manierismo, Classicismo e Barocco, Positivismo e Romanticismo, Razionalismo ed Espressionismo, fino al dibattito tra figurazione ed astrazione, tra realismo ed arte concettuale ancora vivo ai giorni nostri. Spesso questi rapporti dialettici sono stati, dalla storiografia delle varie epoche, personalizzati a loro volta in scontri tra grandi artisti: Raffaello e Michelangelo, Caravaggio e Annibale Carracci, Bernini e Borromini, via via fino a Picasso e Dalì, Matisse e Mondrian, Guttuso e Burri.
Nel secolo appena trascorso, poi, dopo i grandi fermenti rivoluzionari che sembravano aver definitivamente decretato la “morte” dell’arte o quanto meno delle sue forme e tecniche più tradizionali, proprio nell’ultimo scorcio si è assistito a un prepotente e massiccio “ritorno all’ordine” che non è più stato vissuto come qualcosa di passatista o rétro ma al contrario ha assunto esso stesso un aspetto quasi liberatorio o addirittura provocatorio, cosicché oggi possiamo dire che dipingere una natura morta o un paesaggio è attuale così come esporre una istallazione piena di sassi o carta straccia e che un artista informale o concettuale è “moderno” quanto un iperrealista o un neomanierista.
Insomma si può dire che finalmente, non contano più le etichette o gli “ismi” ma piuttosto la qualità della produzione estetica, ed ecco allora che un artista poliedrico e difficilmente inquadrabile in uno schema predefinito come Antonio B. Fraddosio può essere giudicato e apprezzato proprio per l’indubbio fascino e valore delle sue opere. Ma attenzione, essere senza etichettature non significa essere avulso o isolato da quanto si è prodotto finora, tutt’altro; significa piuttosto vivere determinate tradizioni e d esperienze passate come stimoli e non come camicie di forza. Così, come molto opportunamente ha osservato Gabriele Simongini, nel saggio di introduttivo del catalogo della mostra “Tensioni e torsioni” del 2004: «in modi e forme molto personali Fraddosio si ricollega a quella stagione creativa che nella seconda metà del Novecento ha portato alcuni rigorosi artisti italiani a dare vita all’avventura dell’attraversamento e del superamento della superficie della tela verso altre dimensioni» e qui vengono citati Fontana e Burri, Castellani e Manzoni, Bonalumi e Dadaimaino: «Mentre però – continua Simongini – molti degli artisti prima citati erano i cultori di un azzeramento radicale di qualsiasi emozionalità pittorica… Fraddosio non è interessato a fare una tabula rasa troppo radicale. Sa essere per certi versi minimale, dando voce a pochi colori e a strutture essenziali, ma comunque lasciando parlare l’inquietudine di una materia che dà immagine a quelle che si potrebbero chiamare “cartografie dello spirito”, fatte di avvallamenti, anfratti, dirupi, sentieri interrotti, crepacci, pendii dilavati».
Del resto Fraddosio è un architetto, conosce come pochi i risvolti più segreti della materia, sia essa legno, pietra, cartone, cemento, sa quale ordine interno si celi dietro il caos apparente o al contrario come la più classica delle strutture nasconda in sé abissi di ignoto. Proprio dopo aver meditato sulle opere del nostro artista mi è capitato di passare davanti al Pantheon, il più “classico” dei monumenti esistenti al mondo, anzi l’essenza stessa della “classicità” e di notare per la prima volta tra quei marmi e quelle pietre, fessure, sbrecciature che si sono aperte ai miei occhi come voragini improvvise, romantiche percussioni di infinito che mi hanno fatto amare ancor di più quel monumento già da me tanto amato e me ne hanno fatto apprezzare ancor di più la modernità sconvolgente e assoluta.
E allora ho compreso come questo retaggio classico che ogni artista italiano (e parlo ovviamente di artisti veri) porta con sé ne rappresenti la differenza rispetto a pur sommi artisti stranieri. Nel caos disperato di Pollock c’è la ribellione tangibile verso una civiltà metropolitana sempre più frenetica e consumistica ma non c’è, ovviamente, nessuna ombra di ordine o di retaggi del passato; nell’apparente informe casualità dei cretti di Burri vi è invece tutto il rigore concettuale della tradizione storica italiana, cui anche Fraddosio, a suo modo, è molto sensibile.
Tra le opere di Fraddosio che bene riassume la sua poetica mi piace citare Tensioni, in legno, stucco e catrame, del 2000, magistralmente descritta da Rocco Familiari nel suo scritto critico “La parete vivente”.
Ancora un “quadro-parete” è Alterazioni del ’98, che si sviluppa tutto in senso orizzontale e riassume in sé ordine e casualità, classico e anticlassico, rigore e improvvisazione, mentre Lesione, sempre del ’98, tutto incentrato sul contrasto del bianco dello stucco e del bruno del legno, vive di interne tensioni, così come Macrolesioni del ‘2000, con la sua superficie lacerata e piena di fratture. In Dilavamento dell’anno successivo il colore diviene protagonista, con quella colata di arancio che si fa strada quasi a fatica tra il grigio della materia circostante. In Arianna sempre del 2001, un filo sottile si dipana lungo la superficie bianca lasciando impercettibili tracce di sé e recuperando una piena valenza pittorica che diventa quasi esuberantemente barocca in Legature. Mentre la sua esperienza di scenografo emerge in tutta la sua creatività in Torsioni del 2003, con quella grata che fa capolino tra la cascata bianca di stucchi e carta, sbarra di prigione o retaggio neoplatonico che ci riporta fino al Verrocchio e al suo sublime monumento funebre a Piero e Giovanni de’ Medici in San Lorenzo a Firenze. Ed emerge anche in altre sue “Pareti” bianche che sembrano fatte apposta, e spesso lo sono, per fungere da fondali di rappresentazioni teatrali e divenire esse stessi schermi dove proiettare altre immagini, giochi di luce, contrasti di tenebre. Ma la materia, in Fraddosio, diventa sempre più intercambiabile ed allora ecco un lamierino in ferro piegarsi e avvolgersi come carta da paco in Lamiera del 2004, o il legno e il cartone assumere quasi la morbidezza di una stoffa in Permeazioni dello stesso anno. In Compressioni su monolite del 2005 tutta la poetica precedente viene riassunta in queste due pareti in sé autosufficienti che però al contempo si attraggono, si respingono, dialogano e si ignorano, specchio di sé, ma anche un po’ di noi stessi, come osservava appunto Familiari. Il tema del paesaggio urbano, memore dell’informale di Mimmo Rotella e dei suoi cartelloni pubblicitari strappati e ricomposti in un nuovo (dis)ordine affiora ad esempio in Stratificazioni urbane, o in Dislocazione sempre del 2005, fino al drammatico Ruderi metropolitani del 2006, struttura in costruzione lasciata incompiuta o piuttosto residuo di qualche edificio distrutto? Feto mai nato, come lo definisce lo stesso artista?
«La mia ricerca -scrive Fraddosio- è tutta imperniata sull’uso di materiali di recupero, abbandonati nei cantieri o nei laboratori artigiani e che sono stati lasciati lì, in balia dello scorrere del tempo. In questa società che divora e brucia rapidamente tutto, io cerco di recuperare questo materiale, che già ha un passato, la presenza del tempo dentro di sé e lo sottopongo a operazioni che enfatizzano tutta la sofferenza che nasconde al suo interno (che è poi la sofferenza interiore di tutti noi) fino a farne un’opera d’arte». Ed in questa dichiarazione di intenti si misura l’affinità (di cui abbiamo già parlato), ma anche la distanza della poetica di Fraddosio da quella di Burri e dei suoi cretti. Quest’ultimo infatti ri-ricrea artificialmente le alterazioni e le scissioni della materia bruta quasi non fidandosi completamente di essa, non ritenendola degna di entrare così com’è, nella sua nuda crudezza, nell’Olimpo dell’arte.
Fraddosio al contrario si affida completamente ai materiali di scarto, li coltiva, li purifica col suo amore di artista e novello Pigmalione li trasforma in Galatea, li riscatta in autentiche opere d’arte. Operazione questa in apparente perfetta coerenza con la poetica del Concettuale, ma anche qui con qualche notevole differenza. Gli artisti concettuali infatti sono convinti che basti l’intenzione, il gesto, l’atto in sé per trasformare una tela rovesciata, una finestra rotta, un sasso trovato per strada in un’autentica opera d’arte. Fraddosio sa invece benissimo che tutto questo non è sufficiente, che la fatica di mente da sola, senza la conseguente fatica di mano che la supporti, può rimanere un’operazione fine a sé stessa ed allora questi materiali di scarto egli li riplasma, rilavora, “rifatica” fino a piegarli completamente alla propria visione estetica.
Un’operazione dunque che più che a un Kounellis o a un Beuys si richiama a Pier Paolo Pasolini (non a caso definito da Fraddosio “il più grande poeta del Novecento, oltre ogni polemica e altra considerazione”) e alla sua poetica del “Dopostoria”. Nelle periferie degradate di Roma, nelle baracche informi sorte spesso a pochi metri da resti memorabili di acquedotti e archi romani ormai quasi irriconoscibili, lo scrittore/regista, come testimoniano tra l’altro Mamma Roma o La ricotta riconosceva comunque indelebili tracce di quella storia che ci differenzia da ogni altra nazione al mondo; certo è una storia ormai decadente, giunta a un suo dopo, ma che può comunque sublimarsi e riscattarsi grazie alla forza purificatrice dell’arte, cinematografica o poetica nel caso di Pasolini, figurativa e plastica nel caso di Fraddosio. Brandelli di muro come cuori straziati, come scrive un altro grande poeta amato da Antonio, Ungaretti: «Di queste case/non è rimasto/che qualche/ brandello di muro… È il mio cuore/il paese più straziato».
Bisogna poi dire che l’arte di Fraddosio assume nelle sue ultime prove toni sempre più concitati e angosciati, come anche i titoli delle sue opere testimoniano: Scissura, Sfibramento, Vortice, Lacerazione, o ancora Compressioni esplosive, dove la materia viene trattenuta fino allo spasimo di un singulto interiore, dove il tempo diventa esso stesso materia che quasi si può toccare con mano; dove, ancora una volta, l’apparente caos della materia stessa trova un riscatto proprio nella bellezza dell’arte che riesce a sublimare anche il più informe groviglio trasformandolo in un bellissimo principe, quasi Materia al limite, come recita una delle sue composizioni più recenti. Ancora in Decoesioni siamo attratti come in un labirinto misterioso che apre inquietanti misteri (il buio della mente del celebre film di Chabrol?) celati dentro rassicuranti ghirigori di bianco, o sorpresi dal sottile gioco di “mettere” e “levare” che traduce in chiave astratta l’eterno dualismo michelangiolesco del contrasto fra forma e materia in Distorsioni e in altre sue opere recenti che sembrano quasi una rilettura in chiave astratta proprio dei Prigioni del Buonarroti, con le superfici che ora zigzagano in uno spigoloso serpentinato, ora si flettono più dolcemente in spirali quasi barocche.
Le opere di Fraddosio, per ammissione dello stesso artista, non vanno però solo viste, ma in qualche modo vissute, respirate, odorate e allora vi si può cogliere il profumo di salsedine che sempre si porta con sé chi è nato in riva al mare, come il sottoscritto in quel di Messina o come appunto Antonio in quel di Barletta, e allora davanti a certe sue recenti pitture-sculture nuovamente memori di Tapies che paiono relitti di navi, o barche, abbandonate, mi lascio trascinare in poetici ricordi, e mi appare dolce la luna piena che si riflette di sera sulle strade bagnate recidive di primavera e dolce ormai è anche il ricordo della città sul mare dove passeggiavo col cane tra nugoli di zanzare fino alla piazza del Duomo ripiena di puttane: c’erano anche i battoni che ridevano da lontano e io ancora non capivo e me ne andavo pian piano poi il mio cane è morto e son rimaste le zanzare a farmi compagnia in quella città sul mare. E la capacità evocativa delle opere di Fraddosio, specie le più recenti, che recuperano anche forti contrasti cromatici, spaziano dall’alba alla notte, dal gelo di certi bianchi che sembrano evocare scenari degni del Fargo dei fratelli Cohen ai deserti infuocati di un tramonto a Petra o una notte sull’Etna.
Ma quello che più apprezzo in Fraddosio è il suo continuo sperimentare, il suo continuo mettersi in gioco, cercare nuove strade, nuove provocazioni, come la sua recentissima opera, scelta da Pedrag Matvejeviç per rappresentate Fraddosio alla Biennale di Venezia 2011, Bandiera nera sospesa, a mio parere la più bella e innovativa tra tutte le opere esposte al Padiglione Italia e che lo stesso Matvejeviç così descrive: «Una struttura curvilinea, realizzata con i materiali cari all’artista, legno, cartongesso, catrame, imprigionata dentro una struttura di metallo arrugginito. È un oggetto di straordinaria potenza evocativa e simbolica, che meriterebbe di diventare l’emblema di una rassegna che rappresenta uno sforzo inaudito di imporre il senso, l’imprescindibilità, dell’arte, in un tempo e in una società che sembra invece rifiutarla ». Mentre Fraddosio, dal suo canto, così parla della sua opera: «Una bandiera, se non sventola, non è. È un brandello di stoffa appeso. Questa bandiera nera, colore dell’anarchia, dilaniata, è disperatamente ferma in uno sventolio rimasto solo nella memoria, chiusa in una gabbia che invece può muoversi: rotazione, oscillazione, lenta, rapida, agitata. Toccala, spingila, trattienila, inventa un rapporto fisico con lei, sporcati le mani, senti l’odore perché il niente dolore, niente fatica, niente sudore, niente freddo, niente caldo, niente odore, “conquiste” della civiltà occidentale, ci hanno fatto perdere umanità». Io dal mio canto, posso solo aggiungere che se dovessi scegliere una colonna sonora per questo meraviglioso “grido” artistico di Fraddosio non potrei non scegliere l’altrettanto meravigliosa canzone di Jacques Brel Amsterdam e in particolare la sua strofe finale:
Dans le port d’Amsterdam
Y a des marins qui boivent
Et qui boivent et reboivent
Et qui reboivent encore
Ils boivent à la santé
Des putains d’Amsterdam
De Hambourg ou d’ailleurs
Enfin ils boivent aux dames
Qui leur donnent leur joli corps
Qui leur donnent leur vertu
Pour une pièce en or
Et quand ils ont bien bu
Se plantent le nez au ciel
Se mouchent dans les étoiles
Et ils pissent comme je pleure
Sur les femmes infidèles
Dans le port d’Amsterdam
Dans le port d’Amsterdam.
Sergio Rossi